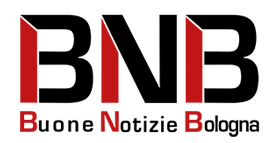A Gender Bender, il laboratorio teatrale a cura di Martina Palmieri/Gruppo Elettrogeno Teatro e Simone Cangelosi.
«Tutte le mattine mi alzo e scelgo di essere… magari diverso da quello che ero ieri». Fu questa riflessione, portata da Zed, uno degli attori di Gruppo Elettrogeno Teatro, a ispirare la regista Martina Palmieri e a spingere il gruppo a cimentarsi con una nuova proposta per il Gender Bender International Festival 2018. Insieme a loro il regista Simone Cangelosi, sabato 27 e domenica 29 ottobre dalle ore 15:30 alle ore 18:30 presso la Palestra dell'Istituto dei Ciechi F. Cavazza di Bologna.
Cangelosi, regista di cortometraggi documentari e montatore, ha lavorato per diversi anni alla Cineteca di Bologna come tecnico restauratore e ha cominciato la carriera cinematografica “documentando” in "Dalla testa ai piedi" (2007) la sua personale transizione di genere. Ne sono seguiti altri lavori, come "Felliniana", con Luki Massa, nel 2010, e "Una nobile rivoluzione", nel 2014, entrambi dedicati alla figura e alla storia di Marcella Di Folco, presidente del “Movimento identità transessuale” e attrice transgender, tra le predilette negli anni Settanta da Federico Fellini e dai più noti registi italiani, come Rossellini, Risi, Monicelli, presentato al 32° "Torino Film Festival".
Gruppo Elettrogeno Teatro, insieme agli attori non vedenti, vedenti e ipovedenti di Orbitateatro torna ora a Gender Bender dopo il felice esperimento nella scorsa edizione con "L'Amore cieco" durante il quale la regista Martina Palmieri ebbe l'occasione di conoscere l'esperienza di Simone Cangelosi che partecipò attivamente alla proposta laboratoriale di quell'anno. Uniti da uno sguardo artistico affine, vicino alle tecniche del contemporaneo e in ascolto dell'altro, i due si sperimenteranno ora, con i facilitatori di Orbitateatro, nella conduzione di un laboratorio aperto a tutte e a tutti, che tra teatro e narrazione indagherà il limite come percorso possibile di esplosione corporea, artistica e identitaria.
Le limitazioni possono anche derivare da diverse predisposizioni sensoriali, e allora quali negoziazioni sono utili o necessarie per rintracciare strumenti e approntare strategie capaci di formare l’identità? In che modo vivo e mi procuro le esperienze che mi fanno sentire, scegliere e essere chi essere? Da quale lente guardo il perimetro del mondo che abito?
Lo scopriremo al laboratorio, qui, intanto, Martina e Simone ci regalano qualche anticipazione:
Martina, Simone, comincerei dall'immagine sottesa al titolo che avete scelto, un titolo che richiama la figura di una persona alle prese con un dubbio, forse al momento del risveglio: “Sono quello che sono perché ho trovato me stesso?”. Come nasce questa domanda e perché avete pensato di estenderla ai partecipanti del laboratorio?
MARTINA PALMIERI: Mi sono ispirata a un precedente lavoro fatto con Zed, uno degli attori transgender di Gruppo Elettrogeno Teatro, che un giorno ha pronunciato una frase molto interessante: «Tutte le mattine mi alzo e scelgo di essere... magari diverso da quello che ero ieri». Una frase che penso rappresenti bene tutte quelle persone che si permettono di avere una visuale più aperta e complessa dell'identità di genere, il che non vuol dire che sia una possibilità esclusiva, è qualcosa che attraverso il teatro chiunque può sperimentare. Alla fine il teatro ti chiede proprio questo, di diventare tutto ciò che è possibile che tu possa diventare, è il teatro in sé che, molte volte, ti indica sul momento l'identità di genere. Succede, banalmente, quando si lavora sui personaggi. Io invito sempre gli attori e i partecipanti ai laboratori a costruirli e decostruirli, anche per privarli di qualsiasi meccanismo di identificazione già sperimentato. È interessante mettersi in gioco in questo senso anche perché ci sono molti comportamenti che ci portiamo dietro che sono legati a quella che nei fatti è la nostra identità di genere, stereotipi e pregiudizi compresi. Il teatro invece in maniera, per così dire, misteriosa e silenziosa, ti chiede di contro di sperimentare che cosa invece puoi essere. Se poi si apre un'altra scatola e emerge qualcosa di più personale, magari legato a differenti predisposizioni sensoriali o a una particolare condizione fisica, il discorso si amplia ulteriormente.
Zed mi ha portato un'altra riflessione a riguardo, a partire da un'esperienza che avevamo avuto con un ragazzo sordo-cieco con cui lavoravamo anni fa. In quel periodo era proprio lui a occuparsi di andare a prenderlo per condurlo ai laboratori e avevano legato molto.
Abbiamo cominciato a sperimentarci su ciò che accennavo, quello che il teatro ti chiama di volta in volta a diventare, donna o uomo o qualcosa di indefinito che sia, partendo dal presupposto che ci sono sempre delle piccole pieghe nell'identità dell'attore e che tutte queste possibilità di fare, di dire, di agire e di comportarsi possono caratterizzare quello che stai facendo ma non per forza dentro un limite stabilito. A un certo punto ci siamo ritrovati al centro di quello che era il cuore del momento, cioè il vissuto di una persona che non aveva avuto nessun tipo di incontro sessuale, né modo di fare esperienze per capire quale fosse la propria identità di genere. Allora Zed ha creato un'improvvisazione in cui andava a toccare questioni che scottavano. Ritrovandosi con una persona con predisposizoni sensoriali così diverse e importanti, in cui per problemi oggettivi si è poco a contatto con il mondo, Zed si è posto un'altra domanda. Se io avessi avuto quel tipo di condizione di vita, si è chiesto, avrei avuto la possibilità di decidere liberamente di essere in transizione? Ecco, la domanda è aperta ma dal lavoro che poi ne è seguito la riposta che mi è sembrato di cogliere da parte sua è: forse no.
Sia a me che a Simone comunque non interessa lavorare sul tema dell'identità di genere in maniera esplicita, ci saranno tutta una serie di esercizi che verranno proposti che ci permetteranno di muoverci in assenza di giudizio, un altro elemento importante perché ci siamo noi che giudichiamo e soppesiamo le nostre parole e gli altri che a seconda del contesto che stai vivendo restano un corpo giudicante. Ci interessa però proporre l'inverso, un lavoro che generi una libertà di essere seguendo degli spunti narrativi che vengono dati per realizzare un lavoro piuttosto che un altro. Un'altra domanda a cui tenterò di dare una risposta attraverso alcuni esercizi sul corpo e lo spazio è : c'è un modo per conoscersi? C'è un altro modo di conoscere il proprio corpo, anche quando non c'è nemmeno l'utilizzo della visione? C'è modo di riconoscere qualcun altro e di raccontarlo?
Su queste cose ci siamo confrontati con Simone e anche se il teatro non è il suo linguaggio, che un po' lo incuriosisce e un po' lo disorienta, gli ho chiesto di scrivere alcune frasi che per me saranno utili a ispirare un lavoro di improvvisazione, che in qualche modo possiamo far esplodere senza esplicitare troppo i contenuti. Simone sarà anche un attento osservatore con cui ci confronteremo passo passo. Ci piacerebbe che questo fosse l'inizio di una collaborazione, una prima occasione con cui sperimentarci insieme in direzione di ulteriori sviluppi.
SIMONE CANGELOSI: Io sono stato coinvolto da Martina, che è il vero motore di questo progetto, e il modo in cui lo farò andrà in parallelo con delle suggestioni che in parte mi ha già dato e in parte mi darà durante il laboratorio, su cui io cerco di dare un contributo creativo in termini narrativi e di scrittura. Sono curioso di vedere che cosa succederà, non essendo io una persona che fa teatro. Il tema che suggerisce la domanda di Zed è molto ampio e ha preso questa direzione a partire da non da una definizione ma da un ricerca di sé in senso lato, in termini di identità di genere e di identità in generale...
Judith Butler, nella prefazione del suo storico “Gender Trouble” sottolinea come la sua scrittura sia nata soprattutto dal desiderio di vivere, di rendere possibile la vita e di ripensare il possibile in quanto tale. Parole che è facile legare al concetto di limite, altro termine chiave in questa sperimentazione...
M.P.: Sì assolutamente. Si tratta di limiti, partenze, che vengono comunque trasformati in qualcos'altro. A teatro, ormai lo possiamo dire, i limiti sono per fortuna l'inizio di una trasformazione. Il teatro offre sempre una metamorfosi. Ciò che è limite nella vita quotidiana a teatro acquista un altro significato, una condizione da cui è possibile raccontare. Il limite a teatro in un certo senso non esiste... O meglio i limiti vengono agiti e proposti in altri modi, finendo per trasformare anche il linguaggio del teatro, una questione dal punto di vista artistico molto interessante. Lavorare con persone con difficoltà sensoriali e cognitive ti porta a dover prendere le misure con questo ma è già il teatro a farlo. Per far emergere l'espressività degli individui è importante partire dalle condizioni da cui lavorano, ma non è fare teatro terapeutico, il teatro lo è intrinsecamente e quindi non lo è. Semplicemente ci sono linguaggi artistici in cui certe cose possono accadere e altri in cui non ne hai la possibilità.
S.C.: Il limite è la condizione del possibile per noi umani che siamo nel distinto e questo bisogno di superare i limiti credo sia alla base dell'azione umana. Chi si interroga sull'identità ovviamente pensa a queste cose ma sono molto più universali, alla base dell'identità umana più che di genere, che si modella costantemente nel tempo. È ovvio che chi è costretto a vivere il limite sul corpo, per come è fatto, e si trova a interrogarsi su di sé, il limite è la prima cosa che pensa ma è un'attitudine umana, esistenziale, non c'è nulla di parziale in questo concetto.

Foto: scena dallo spettacolo
Martina, mi sembra che aprire il laboratorio anche a persone di diversa età, provenienza e a persone con disabilità sia di fatto una derivazione spontanea del percorso che indichi... Simone, per te invece non è la prima volta ma quasi...Sei curioso?
M.P.: Sì, pur nella difficoltà di gestire una tale complessità di persone, per lo più di tipo pratico e logistico, si viene sempre a creare la tensione giusta. C'è una libertà di pensiero e di azione, una ricchezza che per chi conduce va di pari passo con la capacità di modulare in base a ciò che accade e gli accadimenti in queste circostanze sono sempre imprevedibili, più che in altri contesti. Su un corpo ci sono le tracce che tu vivi. Quel vissuto cambia il mio sguardo sulle cose, sul mio modo di approcciarmi al teatro, crea un cortocircuito in cui per me c'è l'aspetto più artistico. Il corpo non racconta solo il dolore di vivere una determinata condizione, racconta l'essere umano presente, il presente del teatro. Non è una scelta lavorare con queste persone, è una necessità. Io non credo sia possibile raccontare quello che siamo senza di loro e non parlo solo di persone con disabilità. Penso agli attori che mi affiancano, ai protagonisti de I Fiori Blu che vogliono dare continuità al percorso che hanno a che fare con il mondo del carcere... Preferisco partire da persone che hanno davvero la necessità di dire qualcosa, come regista lo trovo più interessante. Ripeto, non è una scelta lavorare con persone con disabilità, è una necessità artistica, sono due cose diverse.
S.C.: A volte a definire le cose mi sembra di sminuirle... L'anno scorso ho vissuto questo incontro ma non ho mai pensato di descriverlo o di parlarne tornando a casa. Sicuramente è inaspettato quello che ho visto. L'aspetto performativo permette di immaginare e di mettere in pratica cose che sono dei superamenti e delle grandi occasioni di formazione esperienziale. Quello che ho visto l'anno scorso mi ha molto colpito perché non pensavo che persone con dei limiti corporei oggettivi avessero la chance di fare teatro in questo modo, ricavandosi uno spazio di vivibilità innanzitutto.
Il fatto che un senso o più di un senso sia limitato ma che si cerchi di fare teatro comunque mi ha sorpreso perché non è ciò che nel quotidiano accade. L'ho trovato molto ricco e con una ricaduta sociale, nel senso più positivo del termine, che passa sempre da cose pratiche, dal fare. Dare uno spazio creativo a chi nella quotidianità non può viverlo, in cui si abbattono barriere perché si è tutti allo stesso livello è importante, darsi un linguaggio comune dove chi arriva si inserisce è molto interessante ed è molto utile. L'immediatezza con cui usciamo e andiamo a prenderci un caffè non è l'immediatezza di tutti e così l'accesso al divertimento, la cultura... Ho trovato il modo di fare teatro di GET “spudorato”, volutamente senza pudore con la forza, così, di superare un limite. È così che si fa. Bisogna sempre cercare in quello che fai di mettere al mondo qualcosa che prima non c'era e che quindi serve. Un bel gruppo spudorato, sì.
Quali sono state le affinità che vi hanno spinto a cimentarvi in un percorso d'indagine comune e come avete unito le rispettive vocazioni, teatrale e documentaria?
M.P.: Io mi sono mossa soprattutto a partire dall'interesse che in Simone sta nascendo per la scrittura, un interesse, mi raccontavi, nato dalla tua attività di montatore. Mi ha incuriosito parecchio e l'ho trovato vicino. Anche a me sembra di fare questa operazione, di guardare le cose, di capirle, di smontarle e rimontarle, in sala chiaramente, ma l'ho trovato un punto di contatto stimolante.
S.C.: Sono molto curioso di vedere che cosa accadrà. È tutto molto laboratoriale e per me in questo senso particolare, una nuova modalità. Mi attrae da un lato l'assenza totale di controllo che ho sulla cosa (come saranno utilizzate le mie parole, come reagiranno i partecipanti agli stimoli dati), il modo in cui lavori tu, Martina, e il Gruppo, tenendo aperto il più possibile a quello che deve arrivare dal personale. Sono tanti frammenti che si sedimenteranno che si costruiranno in una narrazione, un modo di procedere completamente diverso da quello che di solito faccio, partendo da un'idea visiva molto precisa, la libertà espressiva che si persegue è molto più materiale, qui, invece, il materiale verrà fuori al momento del laboratorio e noi ci dovremo accordare su questo.
Martina, come regista di Gruppo Elettrogeno/Orbitateatro, nel tempo hai avuto modo di far crescere e elaborare un vero e proprio metodo, chiamato ADT, “Arte Della Trasformazione”. A me, che ho avuto modo di conoscere il lavoro di GET da vicino, viene spontaneo associarlo alla pratica del “coming out”, inteso proprio nell'accezione più ampia del termine, come “momento di insurrezione nell'atto del discorso”...
M.P.: Sì, delle volte esplodiamo delle cose e troviamo delle parole che non pensiamo di avere, che non pensiamo che siano delle nostre risorse o memoria e invece le tiriamo fuori nel momento in cui, per esempio, delineiamo un personaggio da abitare e ti viene chiesto di prendere posizione rispetto a quel personaggio e lì molto spesso gli autori trovano, inventano parole segrete.
S.C.: Ovviamente il “coming out” ha una sua storia precisa e geograficamente collocata ma se pensiamo a cosa è stato per le persone che hanno avuto bisogno di farlo, beh, è sicuramente un grande atto liberatorio, è poter raggiungere qualcosa che per varie ragioni ci viene vietato o che ci vietiamo, perché siamo anche il prodotto di questa società. Per raggiungere il benessere bisogna prima di tutto sconfiggere i propri demoni che ci impediscono di dire chi siamo, per la paura che si ha di sé. Decidere che si ha diritto a due ore di felicità, di performance, in cui poter fare qualcosa che nessuno si immagina... Quanto coraggio ci vuole a fare l'attore? Non tanto a farlo ma a immaginarsi come ci si sente, il darsi dei diritti. La nostra comunità, me compreso, ha vissuto queste cose tanti anni fa e sono quasi un ricordo ma a spingerci a cambiare città, a iniziare delle relazioni omosessuali clandestine, è stato il senso, la consapevolezza di avere la dignità di avere dei diritti. Corpo, limite e identità... Non è un caso che GET li affronti proprio tutti. Bisogna essere coraggiosi, prima di andare nel mondo e prendersi le cose, perché viviamo cresciuti nel “no”, il blocco che resta è la possibilità. Ciò che accomuna chi vive il limite su di sé e il movimento transessuale è forse il cercare di conquistarsi e garantirsi uno spazio di vivibilità. Un progetto teatrale che si pone a ragionare sulle barriere mettendotene una, come la benda, è straordinario perché di fatto la barriera te la toglie, e tutti sono allo stesso livello. È andare nel punto nevralgico della questione a partire dal tuo corpo. Quanta legittimità ti dai a vivere?
Un'ultima domanda per Simone. La Butler pone l'accento sul potenziale eversivo che nasce dall'incontro con corpi che rappresentano l'oscillazione tra due categorie non identificabili, dove “l'oscillazione è una nuova esperienza del corpo”, e “la conoscenza naturalizzata del genere diventa realtà passibile di cambiamento e revisione”.
Secondo te vale per tutti? Perché fa così paura accettare quest'idea? Tu come ti racconti, se lo fai, fuori dalle comunità LGBT?
La transizione ha fatto parte e fa parte della mia vita, è addirittura nel mio curriculum professionale dato che vi ho girato un documentario, fa parte del mio lavoro di regista e quindi è anche un'affermazione ineluttabile, non puoi prescindere da questa cosa.
È chiaro poi che, come immagino, quando tu entri in un negozio non lo fai dicendo «salve sono una donna», allo stesso modo io non entro dicendo «salve io sono un uomo ma ero una donna», se il rapporto, la conoscenza e la situazione porta a ragionare di queste cose è chiaro che ciò è trasparente. Per me la cosa più importante è stato documentarlo perché il film in questo modo è inscritto e, anche se io non ne parlo perché chiaramente non è un argomento di conversazione, è qualcosa che si è inciso perché quella storia che è finita e si è trasformata, è un bagaglio che io mi porto dietro.
Per certi versi il film corrisponde di più a come io considero questo fatto, un DNA, tu sei tutto quello che sei stato. Uno desidera di diventare Simone ma non puoi cancellare Simona, anzi, Simona gli ha permesso di esistere. Tutte le mie trasformazioni sono io. Non avrei potuto non lasciare un diario di quello che stavo vivendo, era una fonte di comunicazione verso gli altri, ancora oggi far vedere il film è il modo più complesso che conosco, che ho, per portare la mia esperienza agli altri. Si è trattato di un atto pubblico che, nonostante perseguissi un intento prettamente artistico, è diventato politico.
Per ulteriori informazioni e iscriversi al laboratorio: www.gruppoelettrogeno.org
Lucia Cominoli
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS